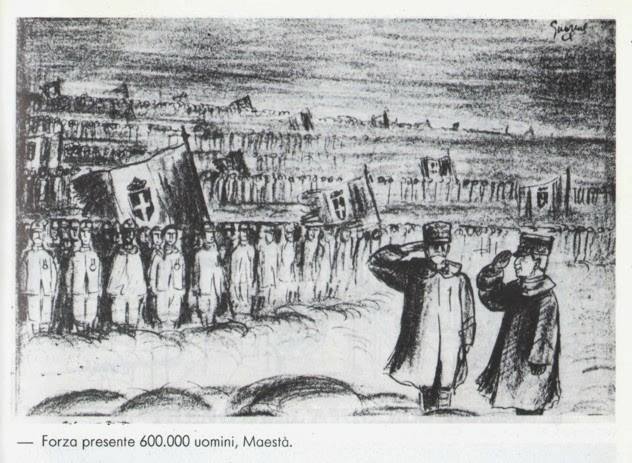Come da tradizione riportiamo,
quando possibile, il testo delle conferenze tenute per il Circolo Rex.
Ringraziamo Gianluigi per la condivisione della sua conferenza del 3 Dicembre!
di Gianluigi Chiaserotti
Armando Vittorio Diaz
nacque in Napoli il 5 dicembre 1861 da Ludovico ed Irene Cecconi, in una
famiglia (di lontana origine spagnola) di militari, di magistrati e di uomini
di Legge.
L’avo Antonio era
stato “ordinatore di guerra” durante
il regno del Re Ferdinando II di Borbone (1810-1859); il padre fu ufficiale del
genio navale nella marina borbonica e quindi italiana; la madre veniva da una
famiglia di magistrati e di professionisti.
Il padre del Nostro,
dopo aver lavorato negli arsenali di Genova e di Venezia (di quest’ultimo era
stato direttore, con il grado di colonnello), morì nel 1871; la vedova con i quattro figli si stabilì in
Napoli, sorretta dalle cure del fratello Luigi, avvocato, vivendo in modesta
agiatezza.
Il Diaz compì gli
studi elementari in varie scuole private, poi, già orientato alla carriera
militare, frequentò la scuola tecnica pubblica, quindi l’istituto tecnico,
traendone una solida cultura scientifica e la capacità di scrivere in una
lingua italiana sobria e corretta; molto tempo dedicò anche agli esercizi
ginnici in palestra. Superati gli esami di ammissione all’Accademia Militare di
Torino, vi prese servizio il 15 settembre 1879; sottotenente di artiglieria nel
1882, frequentò la scuola di applicazione di Artiglieria e Genio di Torino e,
nel 1884, fu assegnato, con il grado di tenente, al 10º reggimento di
artiglieria da campo di stanza a Caserta.
Vi rimase fino al
1890, alternando studio e lavoro con la partecipazione alla vita della buona
società napoletana.
Nel marzo 1890,
Armando Diaz fu promosso capitano e trasferito al 1º reggimento di artiglieria
da campo stanziato a Foligno.
Preparò e superò gli
esami di ammissione alla Scuola di guerra, che frequentò nel 1893-95,
classificandosi al primo posto della graduatoria finale del suo corso.
Il 23 aprile 1895 il
Nostro sposò Sarah De Rosa, di una famiglia napoletana di avvocati e
magistrati: un matrimonio nato all’interno dello stesso ambiente della buona
borghesia napoletana, che si rivelò solido e felice, allietato dopo alcuni anni
dalla nascita di tre figli.
Dal 1895 al 1916 la
carriera del Diaz si svolse prevalentemente negli uffici del comando del Corpo
dello Stato Maggiore, dove lavorò per un totale di circa sedici anni, lasciando
Roma soltanto per diciotto mesi per comandare un battaglione del 26º reggimento
di fanteria, quindi dopo la promozione a maggiore nel settembre 1899, e per
poco più di tre anni, e precisamente dal 1909 al 1912.
A Roma prestò servizio
soprattutto nella segreteria del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generali Tancredi Saletta (1840-1909) prima,
eppoi Alberto Pollio (1852-1914). Un incarico che non lasciava spazio per studi
personali o strategici, ma comportava un confronto quotidiano con la realtà
dell’esercito (organici, bilanci, armamenti) e con il mondo politico romano.
Si rivelò, il Diaz un
lavoratore preciso ed instancabile, capace di far funzionare al meglio i
servizi dipendenti, affabile e diplomatico nei rapporti esterni; non ostentava
interessi politici, ma era bene informato di quanto accadeva in Parlamento e
nel paese ed in grado di destreggiarsi con gli uomini politici e con gli
addetti militari stranieri.
Di statura medio
bassa, tarchiato ma non pesante, con i capelli tagliati a spazzola e grandi
baffi (più tardi ridotti a baffetti), elegante senza esibizioni, di poche e
forbite parole, buon conoscitore del francese e sempre disposto a tornare al
suo napoletano, autorevole ma non autoritario, esigente ma comprensivo, Armando
era un ufficiale che lavorava molto e bene senza mettersi in mostra, sempre
all’altezza della situazione, con una forza interna che si inseriva senza
difficoltà nell’istituzione militare.
Tenente colonnello
dal 1905, nell’ottobre 1909 il Nostro lasciò Roma perché nominato Capo di Stato
Maggiore della divisione di Firenze.
Il giorno 1 luglio
1910 fu promosso colonnello ed assunse il comando del 21º reggimento di
fanteria stanziato in quel di La Spezia, dove seppe accattivarsi l’affetto dei
soldati con un regime disciplinare generoso ed un attivo interessamento alle
loro condizioni di vita.
Nel maggio 1912 fu
destinato in Libia a sostituire il comandante del 93º reggimento di fanteria,
caduto ammalato; e subito ebbe per i suoi nuovi soldati dimostrazioni di
affetto e di fiducia relativamente rare nell’esercito del tempo, ed anche
immediatamente ricambiate.
Il 20 settembre 1912,
nello scontro di Sidi Bilal nei pressi di Zanzūr, fu ferito da una fucilata
alla spalla sinistra mentre conduceva le truppe all’attacco; prima di
abbandonare il terreno volle assicurarsi del successo del suo reggimento e
baciare la bandiera, lasciando poi ai soldati un ordine del giorno di elogio e
ringraziamento.
Armando Diaz fu
quindi rimpatriato con la croce di ufficiale dell’Ordine militare di Savoia.
Nel gennaio 1913,
appena guarito, riprese servizio al comando del corpo di Stato Maggiore
dell’Esercito, come capo della segreteria del generale Alberto Pollio.
Fu confermato in
questa carica dal nuovo Capo di Stato Maggiore Luigi Cadorna (1850-1828), poi,
nell’ottobre 1914, promosso maggior generale, assegnato al comando della
brigata Siena e subito richiamato al comando del corpo di Stato Maggiore come
generale addetto.
Nel maggio 1915, al
momento della costituzione del Comando supremo dell’esercito mobilitato, in cui
Armando Diaz era l’ufficiale più elevato in grado dopo il Cadorna, vi ebbe la
responsabilità del reparto operazioni, che però, malgrado il nome, non si
occupava di operazioni (la cui direzione era accentrata nelle mani di Cadorna e
della sua piccola segreteria), ma dirigeva l’insieme degli uffici e servizi del
Comando Supremo e quindi esigeva una visione complessiva della situazione
dell’esercito.
Diresse l’ufficio con
efficienza e piena soddisfazione di Cadorna per oltre un anno, poi chiese di
andare al fronte; il 27 giugno 1916 fu nominato comandante della 49ª divisione di
fanteria e subito dopo promosso tenente generale.
Tenne il comando
della 49ª divisione per circa 10 mesi, sempre alle dipendenze della 3ª armata,
sul Carso o nelle immediate retrovie.
Sin dall’inizio
dimostrò notevoli capacità professionali e molto impegno nella ricerca dei
maggiori risultati con le minori perdite, predisponendo con grande cura
l’azione dell’artiglieria e gli assalti della fanteria; e guidò con energia le
sue truppe nei sanguinosi combattimenti a nord del San Michele, nel settore di
Veliki, conquistando nell’offensiva autunnale l’altura di San Grado di Merna e,
nel marzo successivo, la dorsale di Voltkoniak con una manovra aggirante.
Per i soldati il Diaz
ebbe sempre un’attenzione costante, controllando personalmente che fossero
rispettati i turni tra trincea e riposo e nella concessione delle licenze, che
tutto il possibile fosse fatto per assicurare un rancio adeguato e regolare,
che nelle retrovie le truppe fruissero di qualche comodità. Non perdeva poi
occasione di interrogare i soldati nelle sue frequenti ispezioni alle trincee e
di incoraggiarli con poche e commosse parole. Dalla Libia aveva scritto che “tutto il segreto è nell’elemento uomo”;
e ora ribadiva: “si comanda col cuore,
con la persuasione, con l’esempio”.
Un atteggiamento che
può parere retorico, come altri gesti del Diaz, ma che in lui era spontaneo,
oltreché piuttosto raro sul Carso, così come la sua riluttanza a punire i
soldati per piccole infrazioni (non transigeva invece sull’obbedienza in
combattimento ed era severo, anche se sempre cortese, con gli ufficiali).
L’interesse per i
suoi soldati e l’impegno con cui cercava di risparmiare le loro vite trovavano
un limite nella sua convinta accettazione degli ordini superiori: un suo
ufficiale di ordinanza, testimonia che Armando Diaz condusse l’offensiva autunnale verso il San
Michele con inflessibile energia, pur ritenendola destinata all’insuccesso.
Le truppe in ogni
caso risposero appieno alla sua fiducia, seguendolo senza cedimenti in tutta la
sua azione di comando.
Il 12 aprile 1917 il
Diaz fu promosso alla testa del XXIII Corpo d’Armata appena costituito e
destinato ancora sul Carso con la 3ª Armata.
Le sue divisioni
entrarono in linea ai primi di giugno nel settore di Castagnevizza e furono
subito oggetto di un violento contrattacco austriaco, che respinsero; poi nei
giorni dal 19 al 21 agosto, nel quadro dell’ultima offensiva italiana sul
Carso, conseguirono buoni progressi a sud di Oppacchiasella, perdendo 8.800
uomini e facendo 4.400 prigionieri; infine in settembre mantennero le posizioni
conquistate malgrado il ritorno offensivo degli Austriaci.
Il Comandante fu
premiato con la croce di commendatore dell’Ordine militare di Savoia; una
leggera ferita da palletta da shrapnel al braccio destro, nel corso di una
ricognizione in prima linea il 3 ottobre, gli valse inoltre una medaglia
d’argento, conferitagli sul campo dal Duca d’Aosta, Emanuele Filiberto di
Savoia (1869-1931), suo diretto superiore
come Comandante della Invitta III Armata.
Il giorno 8 novembre
1917, il generale Armando Diaz fu nominato Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, in sostituzione del generale Luigi Cadorna. Codesta decisione il
Re la prese “nel tratto compreso tra il
ponte della ferrovia e quello della Strada Provinciale per Monselice” come
precisa un’Aiutante di Campo del Sovrano.
Le modalità della
scelta sono ben note nelle linee generali, anche se su singoli dettagli
esistono versioni parzialmente contrastanti dei diversi protagonisti, mai del
tutto composte.
A fine ottobre, al
momento della costituzione del nuovo governo, il presidente del Consiglio
Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952), il Re e il ministro della Guerra,
generale Vittorio Luigi Alfieri (1863-1918) avevano concordato sulla necessità
di sostituire il Cadorna.
La designazione del
generale Diaz come successore era stata fatta da Vittorio Emanuele III
(1869-1947) e dal Ministro Alfieri, quindi accettata da Orlando, ma rinviata al
momento della stabilizzazione del fronte.
Senonché il 6
novembre, nel convegno di Rapallo, gli Anglo-Francesi subordinarono l’invio di
loro truppe in Italia all’esonero immediato di Cadorna, cui addebitavano
l’ampiezza della sconfitta italiana, il disordine della ritirata e il cattivo
funzionamento del Comando supremo.
Ed allora il Re e
l’Orlando presero l’iniziativa di chiamare subito il Diaz alla testa
dell’esercito, aggiungendogli come sottocapi i generali Gaetano Giardino
(1864-1935) e Pietro Badoglio (1871-1956), su indicazione rispettivamente del
Re, di Orlando e di Leonida Bissolati (1857-1920).
Artefice primo della
sua designazione era stato il Re, come abbiamo di già detto, che nelle sue
visite al fronte carsico aveva appreso a stimarlo per le sue doti di comandante
e la capacità di avere rapporti positivi con i soldati e con i superiori.
Ma soprattutto gli
Alleati si ritrovarono insieme in Italia, anche per l’occasione solidale del
loro soccorso al nostro Esercito dopo la rotta di Caporetto. Gli Alleati (Capi
politici e militari) si riunirono a Rapallo (6 e 7 novembre), quindi a
Peschiera del Garda (8 novembre), dove furono gettate le basi per “[…] una miglior coordinazione dell’azione
militare”.
Il Diaz apprese la
notizia della sua alta nomina (del tutto inaspettata, per lui e per tutti) il
pomeriggio del giorno 8 novembre 1917; non esitò e si presentò al Comando
Supremo dicendo al tenente Paoletti: “Mi
hanno dato una spada rotta, ma saprò riaffilarla”.
Immediatamente diramò
un sobrio ordine del giorno all’esercito: “Assumo
la carica di capo di Stato Maggiore dell’esercito e confido sulla fede e l’abnegazione
di tutti”.
Il Nostro scrisse,
tra l’altro, alla consorte: “[…] Il peso
che grava sulle mie spalle è immenso, assai più pesante di quanto possa
immaginare e come base non ho che la mia fede infinita e la fiducia in Dio che
prego mi voglia dare la forza per affrontare il durissimo problema […]”.
Un bilancio del suo
operato come comandante in capo dell’esercito italiano nell’ultimo anno di
guerra non è facile, perché la tradizione e la bibliografia offrono soprattutto
contributi celebrativi, consolidati dalle esigenze propagandistiche del regime
fascista.
Il Diaz ed i suoi
diretti collaboratori non lasciarono testimonianze né studi su questo periodo,
mentre generali illustri come Enrico Caviglia (1862-1945) e Gaetano Giardino
rivendicarono la loro parte nella vittoria con polemiche forzatamente reticenti
e cifrate.
I maggiori studiosi
della guerra italiana, come Piero Pieri (1893-1979) e Roberto Bencivenga
(1872-1949), hanno concentrato la loro attenzione sul periodo cadorniano; e la
relazione dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito è giunta ad
affrontare l’ultimo anno di guerra solo a cinquant’anni dai fatti.
In sostanza, mancano
ancora studi di respiro sul Comando supremo del Diaz, anche se disponiamo di
pagine e giudizi interessanti e di buoni contributi di sintesi su singoli
problemi, in particolare sulle grandi battaglie.
Tutto ciò premesso,
cerchiamo ugualmente di delineare il suo contributo alla vittoria, dando per
noto l’andamento delle operazioni, la battaglia d’arresto sul Grappa e sul
Piave nel novembre-dicembre 1917, la riorganizzazione dell’esercito, quindi la
vittoriosa resistenza sul Piave, che fu esclusivamente difensiva ma avendone
rinnovato, ed in meglio, le forze.
Il 23 giugno 1918,
appena conclusa tale battaglia, Vittorio Emanuele Orlando così telegrafò a
Diaz: “Mi mancano gli elementi per
valutare tutta la grandezza dell’avvenimento e soprattutto se esso abbia
determinato un tale sfacelo morale dell’esercito nemico da rendere
consigliabile di non lasciargli prendere respiro”.
Fu l’inizio
dell’offensiva finale che culminerà in Vittorio Veneto.
Il primo merito del
nuovo Comandante fu, senza alcun dubbio,
la capacità di far funzionare il Comando supremo in modo adeguato alle
esigenze e dimensioni della Grande Guerra.
Anche se non sono
d’accordo in quanto diverse testimonianze, ma anche documenti affermano il
contrario, Cadorna aveva accentrato nelle sue mani troppo potere, mettendosi in
condizione di non poter controllare i dettagli dei suoi piani e l’esecuzione
dei suoi ordini e di non riuscire a capire la gravità dei problemi che
ricadevano sul governo.